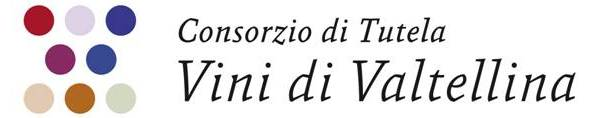La zona di produzione della Valtellina si estende da ovest a est, dal lago di Como a Tirano. Si tratta di un terroir unico al mondo, una zona aspra circondata dalle imponenti cime delle Alpi. La biodiversità è grande e c'è un'enorme diversità geologica e morfologica. Sul versante retico, l'uva prospera su più di 1.000 ettari, tra 270 e 900 metri sul livello del mare, di cui 420 ettari solo sopra i 500 metri. Nel corso dei secoli, questo paesaggio è stato modellato dai terrazzamenti e oggi è la più grande area terrazzata d'Italia dove si pratica la viticoltura, spesso descritta come "eroica".
La Valtellina offre molta natura ed è una destinazione popolare per gli escursionisti, gli appassionati di trekking, gli amanti della natura e, naturalmente, gli amanti del vino. Ciononostante, la richiesta di includere la regione vinicola nel suo insieme nella lista del patrimonio mondiale non è ancora stata accolta. Tuttavia, la linea ferroviaria retica che attraversa il paesaggio dell'Albula/Bernina fa parte di questa lista dal 2008. La linea fu completata nel 1904 e nel 1910 ed è considerata un capolavoro tecnico dei tempi pionieristici della ferrovia. All'epoca, l'offerta era stata presentata insieme alla Svizzera.
 |
In Valtellina si crede nella combinazione di parametri ecologici, economici e produttivi. Dopo molti anni di lavoro per migliorare la qualità del vino in tutta la zona, oggi il focus principale è sulla sostenibilità e la conservazione della biodiversità nel vigneto per produrre vini di grande personalità, freschezza e finezza. In questa zona unica con un paesaggio spettacolare, quasi un solo vitigno è coltivato sulle terrazze: Nebbiolo, un clone autoctono chiamato Chiavennasca. Produce vini complessi, ma generalmente non complicati, che sono apprezzati dagli esperti del settore e dagli amanti del vino.
Nato come una fonte di sostentamento per servire il mercato locale e vicino nel cantone svizzero dei Grigioni attraverso i passi alpini, il vino ha oggi un ruolo importante nell'economia locale. Sul mercato di vendita moderno, deve competere con altre grandi regioni viticole spesso incomparabilmente più conosciute e meno problematiche da coltivare. La Valtellina segna con la natura, la fantasia e la tradizione in movimento.
 |
Il consorzio ha scelto lo slogan "Il Nebbiolo delle Alpi" perché vuole sottolineare il legame indissolubile tra il nobile vitigno Nebbiolo, la viticoltura di montagna e i vini della Valtellina.
L'uva Chiavennasca è considerata autoctona della Valtellina. Tuttavia, questa denominazione non ha niente a che vedere con il nome della città di Chiavenna, che nella storia aveva più a che fare con il commercio del vino che con la sua coltivazione. Il nome deriva dal dialetto locale "ciüinasca", che significa "più adatto alla produzione di vino". Questa varietà regionale del famoso vitigno è stata coltivata in Valtellina fin dal XVI secolo, come testimonia un documento con le istruzioni dei proprietari terrieri ai loro viticoltori su come migliorare le viti: Oltre ai vitigni per i nuovi impianti (Ciüinasca, Pignola, Rossoladura), elencava anche i vitigni vietati, che erano e sono più produttivi ma di qualità inferiore.
 |
Sebbene la Chiavennasca si sia adattata nel corso dei secoli alle particolari condizioni climatiche della Valtellina, possiede ancora le caratteristiche principali dell'uva Nebbiolo da cui discende originariamente. È una varietà a maturazione tardiva che richiede un'esposizione ottimale alla luce del sole. Produce vini complessi con acidità e tannini relativamente alti. Oltre alle più conosciute aree di Nebbiolo di Barolo, Barbaresco, Ghemme, Gattinara e altre in Piemonte, la Valtellina è l'unica area di coltivazione contigua più grande per questo vitigno.
Altri vitigni coltivati qui e "discendenti" del Nebbiolo sono Pignola, Rossola e Prugnola. Tuttavia, sono coltivati solo in piccole quantità, più un po' di Merlot e Pinot Nero.
In Valtellina è facile parlare di ecologia e sostenibilità in viticoltura. I vigneti sono coltivati manualmente senza l'aiuto di attrezzature pesanti. Inoltre, la Chiavennasca ha caratteristiche genetiche che la rendono meno suscettibile ai principali parassiti della vite rispetto ad altri vitigni. Questa caratteristica, insieme alle condizioni climatiche favorevoli, riduce notevolmente gli interventi necessari. Per sostenere ulteriormente la sostenibilità nel vigneto, oltre a ciò che la natura già fornisce, c'è una rete tecnica che supporta i viticoltori nella gestione razionale e permette loro di perfezionare gli interventi critici per la protezione delle piante, la gestione delle erbe infestanti e la concimazione.
I muri di sostegno impilati sono lunghi più di 2.500 km e sono il risultato di secoli di lavoro scrupoloso e di conoscenze tramandate. Così, i punti più soleggiati sono stati strappati alle montagne per piantare le viti che potevano idealmente maturare lì. Per promuovere le misure di terrazzamento, in cui le fessure del terreno e gli avvallamenti venivano riempiti con terra della valle e consolidati da muri a secco, esistevano all'epoca delle locazioni speciali, che erano comuni dal XIII secolo. Si riceveva un diritto d'uso su un'area, che poteva anche essere ereditato, e lo si pagava in natura, il cui ammontare dipendeva dai miglioramenti delle condizioni del terreno e poteva anche essere pagato se il contratto veniva rescisso. Questa è l'unica spiegazione per la quantità di lavoro quasi sovrumana che è andata a creare i vigneti della Valtellina.
Anche la disposizione delle piante è speciale, approfittando sia del sole del mattino a est che del sole pomeridiano e serale a ovest, facendo seguire i filari di viti verticalmente alle formazioni rocciose. L'accesso difficile e spesso in ripida salita alle aree per lo più piccole rende difficile qualsiasi uso anche minimo di aiuti meccanici e di conseguenza tutto il lavoro è fatto esclusivamente a mano. Questo rende la viticoltura in Valtellina molto costosa. Si stima che da 1.300 a 1.600 ore di lavoro siano necessarie per un ettaro di vigneto (in contrasto con circa 300 ore necessarie in media per un vigneto nel paesaggio collinare della Toscana).
 |
In Valtellina oggi si cerca di conquistare una posizione di primo piano tra le produzioni vinicole di qualità. In questo modo, le caratteristiche specifiche dei vini della regione di montagna sono enfatizzate. Questi sforzi sono stati premiati nel 1998 con il massimo livello qualitativo previsto per i vini dalla legislazione italiana: la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Allo stesso tempo, significa anche severi controlli, come previsto dai regolamenti di produzione emessi dal Ministero dell'Agricoltura.
Diamo una panoramica dello stato attuale dello sviluppo con una degustazione attuale, qui in Wein-Plusuna panoramica dello stato attuale dello sviluppo.
Il disciplinare di produzione del Valtellina Superiore DOCG prevede una percentuale minima del 90% di Nebbiolo (Chiavennasca), a cui può essere aggiunto fino al 10% di vitigni autorizzati nella regione Lombardia. Le viti crescono su terreni non molto profondi (terra di riporto su terreno roccioso). La resa non deve superare gli 8.000 kg per ettaro. La gradazione minima per questo tipo di vino è del 12% in volume. L'invecchiamento per almeno due anni, uno dei quali deve essere in una botte di legno, è obbligatorio. Dopo tre anni di invecchiamento in botti di legno, il vino può portare il predicato Riserva.
 |
A causa della particolare adattabilità del vitigno Nebbiolo alle diverse condizioni ambientali, risultano diversi profili aromatici a seconda della posizione, del microclima e della composizione del suolo, da cui, con un po' di esperienza, si può a sua volta dedurre la zona di coltivazione, a patto che i produttori non esagerino con le misure di cantina. Per questo motivo, le uve di ogni singola zona di coltivazione vengono vinificate separatamente. La zona di produzione si estende per 850 ettari dal paese di Buglio in Monte a Tirano e comprende le sottozone geografiche che danno il nome ai più famosi vini della VValtellina Grumello, Inferno, Maroggia, Sassella e Valgella.
Oltre alla zona di produzione stessa, il Valtellina Superiore DOCG può essere invecchiato e imbottigliato anche a Puschlav. Questa valle laterale dell'Adda, che appartiene alla Svizzera, è geograficamente legata alla provincia di Sondrio. Questi vini portano la denominazione aggiuntiva "Stagafassli" sull'etichetta.
Il Superiore con la denominazione Grumello è prodotto sui pendii a nord-est di Sondrio, su circa 74 ettari, su terrazze. La zona prende il nome dall'omonimo castello (Castello di Grumello) che dominava la valle dal XIII secolo. Come tutti i buoni vini Valtellina Superiore, è adatto a molti anni di invecchiamento in bottiglia. Tuttavia, di solito si distingue dalle altre sottozone per un colore più delicato che assume una tonalità marrone più rapidamente.
 |
La sottozona Inferno ha un nome particolarmente impressionante. È dovuto alle dure e inospitali condizioni di lavoro sulle piccole e aspre terrazze difficili da raggiungere. Fa anche molto caldo qui in estate, a causa della particolare morfologia della zona, che ha la forma di una grande baia. Questa sottozona si estende a est di Grumello, tra Poggiridenti e Tresivio. È la sottozona più piccola con 55 ettari.
Maroggia è la zona più giovane riconosciuta come sottozona dal 2002. Il suo nome sembra derivare da "malaroggia" (letteralmente: canale del male), un fiume in una zona impraticabile. Ma in realtà, la zona al centro del comune di Berbenno si presenta come attraente e soleggiata. Maroggia è legata alla persona di Benigno De' Medici, che soggiornò qui a metà del 15° secolo, fece delle buone azioni ed è ancora oggi venerato a livello locale. La sottozona copre circa 25 ettari e quasi tutti i vigneti sono di proprietà del "Consorzio Assovino".
La zona di produzione più antica e probabilmente più conosciuta del Valtellina Superiore si estende sul territorio del comune di Castione Andevenno e a ovest di Sondrio, capoluogo della provincia omonima. La zona è impraticabile ma particolarmente soleggiata. Il suo nome deriva probabilmente dall'omonimo santuario mariano che si erge pittorescamente direttamente sulla roccia scoscesa (pietra sasso -> Sassella). La Sassella è prodotta su circa 116 ettari. I migliori di questi vini, spesso molto eleganti, possono invecchiare incredibilmente bene.
 |
La Valgella, con i suoi 137 ettari, è la sottozona più estesa della Valtellina Superiore e si trova nei comuni di Teglio e Chiuro. La zona di produzione si estende come un ampio nastro lungo le scogliere, le sue singole parcelle di viti di Nebbiolo orientate verticalmente verso sud. In passato, il vino veniva esportato soprattutto nella vicina Svizzera. Il nome Valgella deriva dall'espressione dialettale "Valgel", che si riferisce a un piccolo torrente che scorre dalle Alpi a valle.
Sul sito web del consorzio può essere trovato qui una rudimentale mappa interattiva che mostra approssimativamente la posizione delle aree di produzione.
Lo Sforzato è un vino speciale prodotto secondo una tecnica molto antica e tradizionale, in cui l'uva viene lasciata appassire o rosolare dopo la raccolta. Dopo l'essiccazione, le uve hanno perso il 40% del loro peso, il succo d'uva è concentrato e ha sviluppato i suoi aromi unici. La vinificazione è seguita da 20 mesi di invecchiamento in legno e in bottiglia. Solo allora, e con una gradazione minima di 14% vol, va in vendita. Lo Sfursàt è fatto con la stessa miscela di uve del Superiore. Il vino è secco.
 |
L'area più vasta della zona di produzione a denominazione di origine controllata (DOC); si estende per 50 km sul versante retico della valle da Ardenno a Tirano su circa 130 ettari. Qui, il terreno tende ad essere meno ripido che nelle zone DOCG. Il Rosso di Valtellina DOC, con il suo contenuto alcolico più basso (almeno 11% è prescritto) e il suo gusto fruttato-fresco, si suppone che sia un vino piuttosto leggero per il godimento quotidiano. La miscela di uve è la stessa del vino DOCG. Si possono raccogliere al massimo 100 quintali per ettaro e il vino deve essere maturato per almeno 6 mesi.
La gamma della produzione vinicola della provincia di Sondrio si completa con i vini dell'indicazione geografica (Indicazione Geografica Tipica-IGT, in tedesco g. A.) Terrazze Retiche di Sondrio. Questa indicazione d'origine riguarda sia i vini rossi che i vini rosati e bianchi, sia i vini fermi che il frizzante, il passito, lo Spätlese e anche il Novello. Nella produzione di questi vini non si devono osservare linee guida di produzione troppo rigide. Ciononostante, anche qui si producono talvolta vini di prima classe.
Fondato nel 1976, il Consorzio è stato ristrutturato nel 1997 e ora rappresenta tutti i produttori di uva, le cantine e gli imbottigliatori della zona. Il consorzio è impegnato nel costante miglioramento della qualità del vino e assicura misure di protezione durante la vendemmia, controlla le rese specificate e coordina tutte le misure di commercializzazione. Ha anche partecipato alla creazione della Fondazione Provinea nel 2003, una fondazione che lavora per proteggere le terrazze.